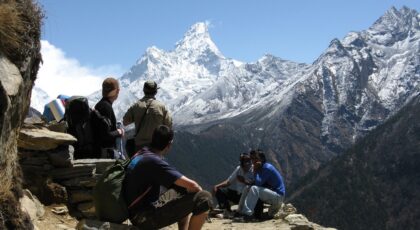Simon Gautier ha 27 anni, è francese ma studia a Roma, ha un progetto: partire dal mare del Cilento e raggiungere Napoli a piedi attraverso le montagne. È un camminatore solitario. Simon arriva a Scario, una piccola località affacciata sul Golfo di Policastro, nel Comune di San Giovanni a Piro, e di là imbocca il sentiero che porta alla spiaggia della Molara. Accampato sotto un cielo di stelle, tra la melodia delle onde che baciano la spiaggia di ciottoli e l’odore del mare, trascorre la notte, forse sognando l’avventura appena iniziata. La mattina seguente si incammina lungo il sentiero per il Belvedere di Ciolandrea, la seconda tappa verso il capoluogo campano. Ma a Napoli non arriverà mai. Per qualche motivo cade in un dirupo, si frattura le gambe, riesce a chiamare il 118, ma purtroppo nel giro di poco la sua vita si spegne. Ci vorranno nove giorni per individuare il corpo dello sfortunato ragazzo e restituirlo alla famiglia. In agosto la vicenda di Simon ha riempito le prime pagine di quotidiani e telegiornali. La sua morte è una tragedia e non ci sono parole solitarie. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi amici. Perché ne parliamo? Per due ragioni: la prima è che dalle parole di numerosi commentatori di quei giorni sembrava che nel nostro Paese chi si fa male o si perde in montagna abbia tragicamente il destino segnato. Non è così. Bisogna dirlo con chiarezza. Sono stati ipotizzati ritardi nei soccorsi, e su questo aspetto farà luce la magistratura che ha aperto un’indagine. Certo, il sistema non è infallibile e non può garantire il 100% di successi, ma non è neppure quella sorta di macchina dell’incompetenza che sembrava emergere in quei giorni. Basta guardare i numeri e gli esiti degli interventi del Soccorso alpino e speleologico del Cai. E ancora, nei “se …” di quei giorni teneva banco il tema del ritardo dell’Italia sull’adozione (già prevista) dei sistemi di geolocalizzazione automatica (ELS, AML) grazie ai quali – questo è il ragionamento – Simon sarebbe stato certamente salvato. Un’affermazione che però attende ancora di essere dimostrata. Perché la tecnologia è un aiuto potentissimo per ridurre i tempi della localizzazione e aumentare le probabilità di trovare in vita un infortunato, dev’essere utilizzata al massimo livello possibile e i gap vanno assolutamente colmati. Ma non basta. Non cadiamo quindi nella fiducia cieca nella tecnologia e soprattutto nel tranello sicuritario secondo il quale avere nel cellulare un sistema automatico di geolocalizzazione ci esoneri da formazione, responsabilità individuale, gestione e accettazione del rischio. Lo ripetiamo sempre: in montagna, il rischio è parte integrante dell’avventura e della libertà. E anche Simon, a mio avviso, lo sapeva e lo aveva accettato: sappiamo che aveva progettato il suo itinerario con cura e che voleva percorrerlo in solitaria. E qui vengo alla seconda ragione. Sul sito marianne.net, il reporter francese Vladimir de Gmeline ha pubblicato un articolo dal titolo Simon Gautier, ode à la liberté d’un jeune homme: È l’unica voce e fuori dal coro che sono riuscito a trovare. Il giornalista, dopo aver sottolineato che la morte del ragazzo è una tragedia e augurandosi che le polemiche su questa vicenda servano a migliorare il sistema (anche in Francia), va dritto alla questione culturale della libertà e del rischio. Si è riaccesa, scrive de Gmeline, la questione dell’opportunità o meno di fare un viaggio del genere da soli. Un dibattito che, secondo il giornalista transalpino, sarebbe privo di senso, oltre che sintomatico di un’epoca in cui alcuni vorrebbero abolire qualsiasi rischio. Siamo perfettamente d’accordo con lui. «Per due giorni – scrive il reporter – numerosi specialisti di ogni tipo ci hanno spiegato che non si deve mai partire da soli per un’escursione, sia in montagna sia al mare, che si tratta di un’imprudenza e di un’incoscienza, “chi pagherà?”, e infine che si fanno correre rischi ad altre persone». Molti hanno consegnato il loro giudizio ai social, comodi di fronte a uno schermo, elargendo consigli gratuiti, tirando fuori qualche aneddoto del solito «cugino che se ne intende». Mi avvio a chiudere questa riflessione prendendo ancora in prestito le parole con cui de Gmeline commenta la cecità (dis)umana e culturale degli “specialisti”: «La libertà, il richiamo degli spazi aperti, il gusto della solitudine, della contemplazione, le lunghe ore trascorse a camminare e a meditare: tutte queste cose non li toccano. Sono figli di un mondo che li ha formattati, bloccati, e vorrebbero che tutti facessero lo stesso. Ciò che Simon ha vissuto – questo giovane libero che amava il bello e lo sforzo –, che ha sofferto, il dolore della sua famiglia e dei suoi amici, fanno finta di non vederlo. Perché di questa libertà, che a volte ha un prezzo che può essere molto pesante, sono gelosi. Questo è il valore supremo, ma il volerlo coltivare richiede un certo coraggio e certo non lo si acquisisce dietro l’anonimato di uno schermo». Come non essere d’accordo? Un verso di Alda Merini recita: «Il grado di libertà di un uomo si misura dall’intensità dei suoi sogni». Simon aveva un sogno intenso e l’anima nell’avventura, e nessuno potrà mai portarglielo via.
Peak & Tip, Montagne360 ottobre 2019